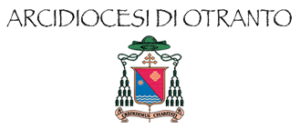La disciplina del diritto di famiglia è dettata principalmente nel libro primo del Codice civile, sostanzialmente modificato dalla riforma del 1975 che ne mutò l’impianto ed i principi regolatori . Oggi è particolarmente accesa nel nostro Paese la polemica su quale nucleo, in cui più persone fanno vita comune, possa definirsi “famiglia”: lo scontro è carico di forti connotazioni ideologiche e le contrapposizioni derivatene finiscono a volte col paralizzare il legislatore e col rendere sempre più flebile la possibilità di sviluppare in Italia un’effettiva politica per la famiglia . In realtà è sempre stato assai difficile pervenire ad un’unica definizione di famiglia, data la vasta gamma di forme sociali primarie che presentano strutture relazionali assai diversificate e dato che il senso, le strutture e le funzioni empiriche attribuite alle tipologie familiari variano secondo i tipi di società in cui sono inserite e secondo l’evoluzione della stessa società .
Anche il diritto -che nasce nella società e ne recepisce inevitabilmente i valori, le concezioni correnti, talvolta i pregiudizi presenti nella cultura della propria epoca e traduce tutto in formule giuridiche- finisce col modellare l’istituto familiare sulla base di esigenze particolari della società del tempo e sulle concezioni, alcune volte ambivalenti ed ambigue, esistenti nella cultura e nel costume . Così, in passato, in una società organizzata essenzialmente come società di famiglie, il diritto prevedeva solo interventi marginali nei confronti della struttura familiare, lasciata prevalentemente alla regolamentazione privata o religiosa . Nel momento in cui si cercò di rafforzare lo Stato, sulla base del primato di un’autorità centrale, la famiglia divenne una struttura portante dello Stato stesso, ma a condizione che si adeguasse a determinati principi autoritari e gerarchici propria della società del tempo .
Di conseguenza, le relazioni interpersonali all’interno del nucleo familiare erano disciplinate dal diritto tenendo scarsissimo conto delle esigenze delle persone e privilegiando le esigenze sociali: al capo famiglia si riconoscevano poteri analoghi a quelli accentrati nelle mani del principe; la dipendenza del figlio dal padre era mantenuta fino a tarda età attraverso la dilatazione della patria potestà; la scelta matrimoniale era subordinata al consenso paterno; il diritto accordato al capo famiglia di battitura e di correzione era riconosciuto nei confronti della moglie e dei figli, soggetti tutti ritenuti bisognosi di una forte guida rispettivamente per l’imbecillitas sexus o l’imbecillitas aetatis. Quando poi gli aspetti economici divenivano rilevanti, la famiglia era disciplinata prevalentemente come un’unità patrimoniale da preservare ad ogni costo e la solidarietà familiare si risolveva nella mera tutela patrimoniale del nucleo cui andavano sacrificati i diritti dei singoli . Infine, nel ventennio fascista, quando l’esigenza predominante fu di contemperare le libertà individuali agli interessi politici e sociali della nazione, la famiglia fu riconosciuta sì come istituzione, ma finalizzata alle esigenze pubbliche: basti pensare alla legislazione per favorire i matrimoni (la tassa sul celibato) o l’incremento demografico (le leggi che favorivano la procreazione).
Il nucleo familiare si connota pertanto non solo sulla base della mutevole realtà sociale, ma anche delle particolari necessità proprie di un determinato contesto storico, e il diritto finisce col recepire le realtà fenomeniche che si presentano nella società e ne ratifica le tendenze prevalenti. Non è un caso che alcune coordinate che fino a qualche anno fa individuavano la realtà familiare sono oggi messe in crisi dall’evoluzione dei tempi. Si pensi, ad esempio, al principio dell’indissolubilità dei rapporti familiari, e quindi all’unicità ed irreversibilità della famiglia e dei legami tra i suoi componenti, che era insito della concezione tradizionale di famiglia. Oggi non è più così. L’ordinamento italiano prevede un rapporto di coniugio che può, infatti, essere dissolto attraverso il divorzio. Inoltre, la famiglia di altri tempi si radicava sul principio che solo la generazione biologica consentiva di far parte del nucleo familiare e che la relazione basata sulla genitorialità biologica era irreversibile: nessun soggetto estraneo poteva essere introdotto nel nucleo formato esclusivamente dai coniugi e dai figli da loro generati; il figlio generato rimaneva tale per sempre. Entrambi questi elementi non sono più validi in modo assoluto e la loro relatività ci introduce in un’altra complessa questione: può considerarsi famiglia la cosiddetta famiglia di fatto?
È innegabile che il modello di famiglia che l’ordinamento giuridico privilegia è quello della famiglia fondata sul matrimonio, perché costituisce la forma giuridica della convivenza di coppia obiettivamente insuperabile per garanzie di certezza, stabilità dei rapporti e serietà dell’impegno assunto. La Carta costituzionale -che proclama questa preferenza- sancisce però che i figli, anche se nati fuori del matrimonio, devono godere di diritti analoghi a quelli dei figli legittimi. L’ordinamento civile italiano ritiene che i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori nei confronti dei figli debbano essere identici, sia che si nasca in una famiglia legittima che in una cosiddetta naturale. Né questo diritto del figlio si risolve solo in prestazioni patrimoniali, perché le disposizioni anche recenti adottate dal legislatore, escludono categoricamente che sussista solo un obbligo alla mera prestazione alimentare. Bisogna riconoscere che una mera convivenza tra un uomo ed una donna, in presenza di figli comuni o generati da precedenti relazioni, pone in essere un agglomerato sociale che non può definirsi tecnicamente famiglia in senso tradizionale, ma che con una famiglia ha molte caratteristiche in comune. Manca, è vero, tra i genitori il vincolo del coniugio, ma tra genitori e figli si pongono in essere relazioni familiari che sono identiche a quelle che si sviluppano nella famiglia legittima.
In realtà, il problema se si sia o non si sia costituita una famiglia di fatto può sorgere solo quando la convivenza tra un uomo e una donna sia divenuta feconda con la nascita di figli che i genitori hanno voluto giuridicamente riconoscere. Solo il riconoscimento stabilizza inevitabilmente il nucleo in quanto il nuovo legame di filiazione, che è pubblicamente assunto nei confronti della comunità, comporta diritti e doveri, che non possono essere più recisi a meno che non sopravvenga l’abbandono del figlio, ipotesi comune anche alla famiglia legittima. Il tema della cosiddetta famiglia di fatto -di cui si vorrebbe uno specifico riconoscimento giuridico- è un tema che al più potrebbe essere preso in considerazione solo quando due adulti che convivono more uxorio hanno generato prole, perché solo in questo caso hanno assunto pubblicamente significativi legami giuridici di natura familiare. Tutti gli altri casi che sono via via prospettati nei dibattiti pubblici rientrano in forme di convivenza tra persone che non assumono i connotati di una famiglia, cioè nuclei che non sono legati da vincoli liberamente e pubblicamente assunti per assolvere in modo potenzialmente duraturo a funzioni familiari per un comune sviluppo umano. Sono convivenze che si radicano sui motivi più vari: religiosi, ideologici, assistenziali, di reciproca cura, di divisione delle spese correlate alla coabitazione e così via. Tutte queste convivenze possono trovare una regolamentazione giuridica per aspetti particolari (fiscali, di subentro nei contratti locativi), senza che questo intacchi in alcun modo quel principio di favore che la nostra Carta costituzionale ha chiaramente espresso nei confronti di quel nucleo che, radicandosi sul matrimonio, costituisce la forma giuridica della convivenza di coppia eterosessuale obiettivamente insuperabile per garanzie di certezza, stabilità dei rapporti e serietà dell’impegno assunto.
L’attuale ed arbitraria volontà del legislatore statale di voler adeguare ai tempi la struttura naturale del matrimonio sta ponendo in essere non una riforma dell’istituto matrimoniale, ma una sua sostituzione con un altro e nuovo istituto giuridico . È come se si volesse lasciare immutato il nome ufficiale di “matrimonio”, sostituendone però in realtà l’essenza e facendogli cambiare significato. Le tendenze riformatrici sono di una tale invasività che, in un futuro forse non troppo lontano, solo i cittadini legati alla tradizione ebraico-cristiana continueranno a difendere in Occidente il matrimonio nella sua struttura naturale di unione tra un uomo ed una donna, destinata a durare tutta la vita ed aperta ad una procreazione vissuta in maniera umana .
[1] Per i rapporti tra diritto di famiglia e trasformazione della famiglia italiana, cf G.C. Blangiardo, Nuove forme familiari e problemi sociali, in Vita e pensiero 10 (1994), pp. 648-664; idem, Formazione e instabilità matrimoniale prima e dopo il divorzio, in G. Campanini (a cura di), Le stagioni della famiglia, Milano, 1994, pp. 189-200; A. Golini (a cura di), Tendenze demografiche e politiche per la popolazione, Bologna, 1994.
[1] Cf. AA.VV., Politiche per la popolazione in Italia, Torino, 1994; R. Palomba (a cura di), Crescita zero, Firenze, 1991.
[1] Cf. S. Grygiel, Amore e lavoro si sono ammalati, in Nuntium 9 (1999), pp. 136-138; L. Melina, Se libertà e natura vengono superate, in Nuntium 9 (1999), pp. 139-141; A. Scola, «Pensare» la differenza, in Nuntium 9 (1999), pp. 143-145.
[1] La storia riporta risposte anche molto differenti fra loro alla questione del senso e del contenuto della vita in comune tra uomo e donna nel matrimonio. Cf. J.J. Bachofen, Il matriarcato, Torino, 1988; J.F. Thiel, Il fattore antropologico-culturale nell’istituzione del matrimonio, in Concilium 5 (1970), pp. 25-39; L. Vincent Doucet-Bon, Le mariage dans le civilisations anciennes, Paris, 1975.
[1] Cf. G. Vismara, L’unità della famiglia nella storia del diritto in Italia, in Scritti di storia giuridica, Milano, 1988, pp. 3-44.
[1] È significativo come i grandi movimenti del XIX secolo abbiano sviluppato non soltanto una determinata teoria dello stato e dell’economia, ma anche una specifica concezione della sessualità e del matrimonio. Cf. F. Engels, L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato. In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan, Roma, 1963; V.I. Lenin, L’emancipazione della donna, Roma, 1971.
[1] Cf. A. Manoukian, Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo, Bologna, 1974.
[1] L’ordinamento -per tutelare il cittadino in età minore che per la sua evoluzione psico-fisica ha estremo bisogno di un valido ambiente familiare- ha sancito che, quando le relazioni genitoriali siano del tutto insufficienti, possano essere troncati rapporti familiari basati esclusivamente sul legame biologico e assicurata al minore, attraverso l’adozione, una nuova famiglia che diventerà la sua esclusiva famiglia in ogni senso. Il temine “figlio di” non è più sinonimo di “nato da” e la genitorialità nell’affetto è divenuta non meno rilevante della genitorialità biologica.
[1] Per il filosofo spagnolo Gustavo Bueno, ad esempio, il governo socialista di Jose Luis Rodriguez Zapatero mirava alla creazione di un mondo assurdo e bizzarro, molto somigliante al Paese delle Meraviglie dove si avventurò il personaggio di Alice nella celebre opera di Lewis Carroll. G. Bueno, Zapatero y el Pensamiento Alicia. Un presidente en el País de las Maravillas, Madrid, 2006, p. 10: «El Pensamiento Alicia procede representándose un mundo distinto del mundo real, y no sólo esto, sino, lo que es más interesante, un mundo al revés de nuestro mundo, como es propio del mundo de los espejos».
[1] Cf. V. Fasano, Le mariage civil en France au lendemain de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, in Angelicum 90 (2013), pp. 331-342.
Vincenzo Fasano
Avvocato della Rota Romana